[ 12 maggio ]
Il Parlamento di Strasburgo decide oggi se considerare quella cinese una "economia di mercato" o no. Da questa decisione potrebbe dipendere (ma la parola finale spetta ovviamente a Commissione ed Eurogruppo) se la Ue risponderà con dei dazi sulle importazioni dalla Cina.
Davvero singolare, assolutamente da leggere, l'intervento di Adriana Cerretelli sul Il Sole 24 ore di oggi —L'Europa si mobiliti contro la Cina statalista. In nome del liberismo più sfrenato si condannano "statalismo e dirigismo" cinesi... per invocare quindi misure euro-protezionistiche. E pensare che quando noi chiediamo simili misure a tutela del lavoro in Italia siamo da Lorsignori bollati come "populisti" e "nazionalisti"...
Il Parlamento di Strasburgo decide oggi se considerare quella cinese una "economia di mercato" o no. Da questa decisione potrebbe dipendere (ma la parola finale spetta ovviamente a Commissione ed Eurogruppo) se la Ue risponderà con dei dazi sulle importazioni dalla Cina.
Davvero singolare, assolutamente da leggere, l'intervento di Adriana Cerretelli sul Il Sole 24 ore di oggi —L'Europa si mobiliti contro la Cina statalista. In nome del liberismo più sfrenato si condannano "statalismo e dirigismo" cinesi... per invocare quindi misure euro-protezionistiche. E pensare che quando noi chiediamo simili misure a tutela del lavoro in Italia siamo da Lorsignori bollati come "populisti" e "nazionalisti"...
Qui sotto un articolo che ci aiuta a capire cosa accade all'interno del sistema politico cinese.
«La recente sortita di Xi Jinping, cioè del leader in carica della Cina postdenghista, di voler procedere ad inviare gli uomini di cultura nelle campagne perché “imparino dai contadini” e poi intessano le lodi della direzione del regime per le sue lungimiranti scelte politiche e sociali ha suscitato più di un commento e ha dato luogo a perplessità di vario genere. E questo perché è sembrato che Xi volesse rinverdire i fasti di Mao Zedong che già nel 1942, nello staterello di Ya-nan dove si era insediato dal termine della “lunga marcia”, era ricorso a procedure del genere per consolidare la sua preminenza nei confronti degli “internazionalisti” più sensibili al dettato del centro moscovita, o quando dalla metà degli anni ’60 ritenne utile avviare iniziative di questo tipo per sancire la superiorità inappellabile del suo “pensiero” nella aspra lotta che lo aveva giustapposto a Liu Shaoqi e Deng Xiaoping e che, in buona sostanza, aveva indotto il “grande timoniere” a scatenare la “rivoluzione culturale”.
Oggi Xi Jinping, che esprime gli interessi e gli orientamenti delle nuove ali emergenti della burocrazia dominante, sembra che voglia rilanciare metodiche e tematiche del genere, anche se in un contesto radicalmente diverso, in quanto Xi e i suoi si orientano oggi per una vistosa accentuazione dell’utilizzo delle categorie di mercato per rilanciare lo sviluppo delle forze produttive e quindi a porsi in totale antitesi ai canoni del “maoismo” più ortodosso che notoriamente patrocinava un’applicazione rigorosamente centralistica e rigidamente burocratizzata dell’economia di piano.
Il fatto è che nella Cina odierna matura una situazione estremamente contraddittoria e complessa che trae la sua ragion d’essere dalla stessa esperienza riformatrice avviata da Deng Xiaoping nel ’78 quando, malgrado lo sviluppo complessivo delle forze produttive tutt’altro che inessenziale che la Cina postrivoluzionaria poteva effettivamente vantare nel momento dato, si determinò un’impasse da imputare tanto alla gestione complessiva del potere e alla centralizzazione esasperata che escludeva ogni coinvolgimento della società civile, quanto alle dilanianti lotte intestine che avevano giustapposto i dirigenti più autorevoli; e questo suggerì a Deng e a quanti gli si raccoglievano attorno una svolta che ridesse impulsi e stimoli al processo produttivo e lo cavasse fuori dalle sacche inerziali in cui l’aveva cacciato il vuoto ideologismo del “maoismo” più ortodosso, dove, sia detto di passata, l’esaltazione delle virtù cerebrali del capo carismatico si fondevano con le procedure repressive per chiunque dissentisse.
In concreto si pensò bene di inserire alcuni elementi delle categorie dell’economia di mercato all’interno dell’economia di piano che nelle sue intelaiature di fondo, almeno nel momento dato, si voleva che restassero fondamentalmente pianificate. Per di più il progetto di Deng, tra esitazioni frenanti e rilanci problematici, comportava un’apertura abbastanza spregiudicata ai capitali stranieri che affluivano copiosi in Cina dove incrociavano una manodopera estremamente abbondante che si riversava nei centri urbani dopo che nel mondo rurale, con lo scioglimento delle “comuni”, si era determinata un’eccedenza che superava i 200 milioni di unità lavorative; insomma il basso costo della forza-lavoro consentiva di applicare un prezzo più basso alle merci che potevano poi essere competitive sul mercato internazionale, mentre lo Stato cinese, grazie ad una politica fiscale abbastanza efficace, poteva accumulare riserve ingentissime di valuta straniera, dollari in primo luogo.
Non si può non riconoscere come quel progetto abbia riscontrato, almeno in termini complessivi, successi economici di tutto rilievo. E’ incontestabile che la Cina abbia conosciuto uno sviluppo estremamente sostenuto delle forze produttive sino a configurarsi come le seconda potenza economica mondiale, alle spalle solo degli Stati Uniti; i consumi sono vistosamente aumentati in tutte le fasce sociali; le riserve in dollari hanno raggiunti livelli senza precedenti. Tuttavia lo schema di sviluppo adottato – e le sue accentuazioni in corso d’opera messe a punto da Jiang Zemin e Hu Jintao – ha mostrato gli inevitabili risvolti negativi. E non solo per la paradossale corruzione che ha coinvolto in lungo e largo tutte le strutture dello Stato e del partito – solo di recente contrastata con una certa risolutezza dalla direzione compattatasi attorno a Xi Jinping -, ma per la distruzione quasi sistematica di tutti i garantismi sociali che in epoca “maoista” erano stati in qualche maniera assicurati e soprattutto perché si sono prodotte sperequazioni sociali e differenziazioni di reddito incredibili. Valga per tutte la valutazione di alcuni studiosi occidentali che ritengono di poter sostenere come i 500 uomini più ricchi della Cina possano vantare un reddito pari a quello di 900 milioni di persone per due anni; o l’altra attribuita alla Banca mondiale che ha riferito come nel 2010 l’1% si è appropriato del 41% del reddito nazionale; e questo magari nel nome di un non meglio identificato “socialismo con le caratteristiche cinesi”, dove, come si commenta sotto voce a Pechino, le “caratteristiche cinesi” sono evidenti, mentre del “socialismo” non c’è più traccia di sorta.
Tuttavia, al di là di ovvie considerazioni su un modello di sviluppo che ha visto privilegiare la sorte di strati sociali ben precisi, è evidente come tutto ruotasse attorno ad un aggancio al mercato mondiale, vuoi per la penetrazione dei capitali che dovevano sostenere gli investimenti, vuoi per la destinazione delle merci prodotte grazie allo sfruttamento più bestiale di una forza-lavoro alla quale era sistematicamente negata ogni forma di difesa o di rappresentanza sindacale; bastava il verbo sufficiente propinato di volta in volta dalle eminenze grigie del regime o dalla fazione che prevaleva al termine di faide furibonde per garantirsi il controllo dei centri di potere che contano.
Questo quadro di riferimento che ha comunque garantito uno sviluppo complessivo delle forze produttive ha di fatto conosciuto una brusca contrazione con lo scoppio della crisi nel mondo occidentale nel 2008; in pratica i capitali hanno cominciato ad affluire in Cina in maniera meno copiosa, mentre le merci cinesi non trovavano adeguatamente acquirenti fuori dai confini nazionali. Come conseguenza si doveva registrare il fallimento di 67.000 aziende piccole e medie, con conseguente licenziamento di circa 20 milioni di lavoratori che dall’oggi al domani andavano ad ingrossare le file dei disoccupati. Il gruppo dirigente che nel momento dato si raggruppava attorno a Hu Jintao si vide costretto a reagire non fosse altro per evitare ricadute sul piano sociale dalle ripercussioni imprevedibili; venne così lanciato un piano di investimenti pubblici pari a 642 miliardi di dollari per rilanciare uno sviluppo che, rimesso a se stante, sembrava avviato verso un tendenziale declino.
Il risultato è stato comunque estremamente contraddittorio; da un lato infatti il declino economico è stato in qualche maniera arginato, ma al tempo stesso questa poderosa emissione di danaro da parte delle autorità centrali contribuiva ad alimentare il debito pubblico che, secondo le stesse stime ufficiali, raggiungeva l’astronomico ammontare complessivo di 3,4 trilioni di dollari, anche se su questo dato ha influito in maniera considerevole l’azione dissennata degli organismi periferici che, pur di far fronte alle esigenze più disparate, non hanno esitato a lasciare penetrare capitale speculativo (hot money) previa l’iniziativa non proprio ortodossa delle “banche ombra” (shadow banks), con il risultato non esattamente incoraggiante di contribuire a determinare una vera e propria crisi del debito (credit crunch), con il conseguente rischio di dare luogo ad una catastrofica crisi finanziaria generalizzata. A ciò si aggiungevano spinte che portavano alla sovrapproduzione (overcapacity) di alcuni settori primari e la tendenza a far convergere risorse cospicue verso una sorta di finanziarizzazione dell’economia, nel senso che troppe risorse finivano con l’essere dirottate verso il settore bancario piuttosto che verso l’economia reale e i settori produttivi.
In breve un contesto di fattori che ha indotto la nuova leadership che è emersa al XVIII Congresso del PCC a varare una sorta di svolta pur di rimettere in piedi l’andamento del processo produttivo che ormai presentava pericolosi sintomi di deterioramento. In pratica niente più stimoli statali per sostenere l’economia – come patrocinato sinora da Hu Jintao e i suoi – ma snellire le procedure e annullare i controlli preventivi degli organismi centrali, per poi rimettersi alle forze salvifiche e propulsive del mercato; di conseguenze oltre 300 provvedimenti che prima richiedevano la preventiva autorizzazione delle autorità governative ora possono essere liberamente messi in atto dalle imprese private; nel contempo molte funzioni venivano delegate a quelle autorità periferiche che poco prima erano state additate al pubblico ludibrio come le maggiori responsabili di quel debito pubblico che aveva raggiunto importi astronomici sin da mettere in dubbio la capacità dell’intero sistema di reggere nei tempi medi o lunghi.
Tuttavia il quadro complessivo che deriva dall’adozione non proprio organica di questi provvedimenti rimane caratterizzata da grande incertezza. Resta inteso che la Cina può ancora vantare un tasso di crescita abbastanza sostenuto, in virtù anche del rafforzamento dello yuan e del dinamismo sui mercati internazionali dove l’ampia riserva di valuta estera ammontante a circa 3.300 miliardi dollari consente alla Chinese Investment Coorporation di finanziare operazioni estremamente efficaci. Ma è chiaro che tra le mura domestiche si delineano tendenze che marcano un declino sostanziale e il venir meno delle spinte più dinamiche e propulsive di quella “riforma” avviata da Deng Xiaoping nel’78 che sinora aveva assicurato tassi di crescita estremamente sostenuti. I dati statistici al riguardo appaiono incontrovertibili; se infatti prima della crisi del 2008 la Cina poteva vantare un incremento del PIL che si aggirava attorno al 14,7% annuo, nel 2013 si è passati al 7,3%, mentre per il 2015 gli analisti pronosticano il 6,8% e per il quinquennio 2020-2025 si prevede un saggio di crescita che dovrebbe oscillare attorno al 3,9%.
Chiaramente questi dati previsionali impongono cautela e attendono la verifica empirica dallo sviluppo degli eventi; tuttavia è indubbio come già ora si delinei la precarietà del progetto di Xi Jinping, se è vero che in men che non si dica si è proceduto a prospettare significative correzioni, per cui di recente si è parlato di nuovi “stimoli” governativi – cioè si fa riferimento ancora una volta a quelle procedure che sembravano in auge quando a menare la danza era Hu Jintao e che erano state giubilate come inadeguate – che per 2015 dovrebbero raggiungere il valore di 115 miliardi di dollari. Con quali ripercussioni sulla dilatazione del debito pubblico non è dato di conoscere.
Difficile valutare in anticipo le ripercussioni sociali e politiche in relazione alle prospettive che sembrano delinearsi nella Cina postdenghista, anche se il regime, magari con disinvoltura degna di miglior causa, persiste nel presentare il tutto come perfettamente in linea con il proprio progetto che d’ora innanzi porrebbe l’accento in misura prioritaria sullo sviluppo “intensivo”, il rinnovo tecnologico autoctono – e non più mediato dalle importazioni dei manufatti stranieri – e l’aumento dei consumi interni in modo da puntare in maniera decrescente sulle esportazioni.
Tuttavia, al di là di queste valutazioni ispirate ad una logica più che altro autogiustificativa, è chiaro come la tendenziale riduzione del saggio di crescita ponga in prospettiva seri problemi ai vertici del regime, quell’apparato dominante che ha progressivamente annullato tutte le caratteristiche che la società cinese aveva assunto al termine dell’esperienza rivoluzionaria e che, a dispetto della più recente ricerca di un quadro di riferimento ispirato ad una maggiore ortodossia legalitaria, continua a gestire il potere in maniera quasi esoterica e comunque al riparo da qualsiasi coinvolgimento provenga dalla società civile.
In concreto un intersecarsi di fattori che potrebbe delineare il logoramento di quel “patto non scritto” – di cui ha parlato più di un osservatore occidentale – secondo il quale la società civile continuerebbe ad accettare di essere espropriata dell’esercizio dei propri diritti politici, in cambio di uno sviluppo che garantisca migliori condizioni di vita; il che, viste le tendenze che si delineano all’orizzonte, sembra che vacilli paurosamente, liberando forze centrifughe e spinte eterogenee rivolte a riconsiderare il contesto dei problemi all’ordine del giorno al di là dei canoni un po’ angusti proposti dai detentori intangibili del potere. Anzi, processi di questa natura già si delineano all’orizzonte e già operano sotto traccia se gli “incidenti sociali” nel 2011 hanno superato quota 200.000, mentre episodi del genere nel 2013 e nel 2014 si sono moltiplicati a tal punto da indurre le eminenze grigie del regime a disporre la sospensione della diffusione dei dati.
In breve un contesto di elementi di giudizio che ha indotto i vertici del regime ad assumere qualche iniziativa per ricompattare quel corpo sociale dove ormai pullulano le spinte più dissimili e le pulsioni più disparate. In primo luogo si è proceduto ad una paradossale quanto anacronistica rivalutazione della figura di Confucio e quindi delle sue elaborazioni attinenti “l’armonia sociale”dove, per uscire da ogni metafora puramente allusiva, tutto si riduce alla più passiva accettazione dei classi subalterne delle scelte e della opzioni messe a punto dal potere costituito. Poi si è passati ad una riesumazione della concezione “maoista” della “linea di massa” che, al di là delle successive interpretazioni apologetiche, si è sempre tradotta in un coinvolgimento dei settori popolari su progetti elaborati dal ristretto nucleo dirigente del partito, sul quale, manco a dirlo, le “masse” non sono mai state chiamate a dire la loro in fase di elaborazione, né a proporre modifiche al momento della loro esecuzione.
Infine la prospettiva di irregimentare in anticipo gli intellettuali – prospettando loro la possibilità di essere inviati nelle campagne a “imparare dai contadini”– perché con ogni probabilità si ha motivo di ritenere che proprio dagli uomini di cultura potrebbero venir fuori le riflessioni più significative sulle scelte di fondo messe a punto dal potere costituito, per poi dare luogo a progetti che delineino effettive soluzioni alternative; insomma chi di dovere intenda che non sarà dato spazio di sorta ad elaborazioni che sortissero autonomamente dal corpo sociale e che eventualmente trovassero proprio negli intellettuali il terreno fertile per messe a punto antitetiche a quelle propinate dall’apparato dominante.
In definitiva di fronte alle ipotetiche tensioni sociali che la Cina di qui a breve potrebbe conoscere l’alternativa è posta: o ci si adegua al ricompattamento sociale di orientamento paternalistico-correttivo prospettato dalla nuova dirigenza emersa al XVIII Congresso del PCC o si dovranno subire le mene repressive della burocrazia dominante, magari finendo in qualche anfratto remoto delle campagne cinesi.
Un progetto che, ad ogni buon conto, si dovrà commisurare con lo sviluppo effettivo degli eventi e con numerose variabili di natura economica, sociale e politica difficilmente valutabili al momento. E non è detto che nella Cina di Xi Jinping tutto fili liscio secondo le aspettative dei vertici del potere. Nella Cina postdenghista le incertezze e le previsioni dubitative prevalgono nettamente sulla consistenza dei dati certi».
Oggi Xi Jinping, che esprime gli interessi e gli orientamenti delle nuove ali emergenti della burocrazia dominante, sembra che voglia rilanciare metodiche e tematiche del genere, anche se in un contesto radicalmente diverso, in quanto Xi e i suoi si orientano oggi per una vistosa accentuazione dell’utilizzo delle categorie di mercato per rilanciare lo sviluppo delle forze produttive e quindi a porsi in totale antitesi ai canoni del “maoismo” più ortodosso che notoriamente patrocinava un’applicazione rigorosamente centralistica e rigidamente burocratizzata dell’economia di piano.
Il fatto è che nella Cina odierna matura una situazione estremamente contraddittoria e complessa che trae la sua ragion d’essere dalla stessa esperienza riformatrice avviata da Deng Xiaoping nel ’78 quando, malgrado lo sviluppo complessivo delle forze produttive tutt’altro che inessenziale che la Cina postrivoluzionaria poteva effettivamente vantare nel momento dato, si determinò un’impasse da imputare tanto alla gestione complessiva del potere e alla centralizzazione esasperata che escludeva ogni coinvolgimento della società civile, quanto alle dilanianti lotte intestine che avevano giustapposto i dirigenti più autorevoli; e questo suggerì a Deng e a quanti gli si raccoglievano attorno una svolta che ridesse impulsi e stimoli al processo produttivo e lo cavasse fuori dalle sacche inerziali in cui l’aveva cacciato il vuoto ideologismo del “maoismo” più ortodosso, dove, sia detto di passata, l’esaltazione delle virtù cerebrali del capo carismatico si fondevano con le procedure repressive per chiunque dissentisse.
In concreto si pensò bene di inserire alcuni elementi delle categorie dell’economia di mercato all’interno dell’economia di piano che nelle sue intelaiature di fondo, almeno nel momento dato, si voleva che restassero fondamentalmente pianificate. Per di più il progetto di Deng, tra esitazioni frenanti e rilanci problematici, comportava un’apertura abbastanza spregiudicata ai capitali stranieri che affluivano copiosi in Cina dove incrociavano una manodopera estremamente abbondante che si riversava nei centri urbani dopo che nel mondo rurale, con lo scioglimento delle “comuni”, si era determinata un’eccedenza che superava i 200 milioni di unità lavorative; insomma il basso costo della forza-lavoro consentiva di applicare un prezzo più basso alle merci che potevano poi essere competitive sul mercato internazionale, mentre lo Stato cinese, grazie ad una politica fiscale abbastanza efficace, poteva accumulare riserve ingentissime di valuta straniera, dollari in primo luogo.
Non si può non riconoscere come quel progetto abbia riscontrato, almeno in termini complessivi, successi economici di tutto rilievo. E’ incontestabile che la Cina abbia conosciuto uno sviluppo estremamente sostenuto delle forze produttive sino a configurarsi come le seconda potenza economica mondiale, alle spalle solo degli Stati Uniti; i consumi sono vistosamente aumentati in tutte le fasce sociali; le riserve in dollari hanno raggiunti livelli senza precedenti. Tuttavia lo schema di sviluppo adottato – e le sue accentuazioni in corso d’opera messe a punto da Jiang Zemin e Hu Jintao – ha mostrato gli inevitabili risvolti negativi. E non solo per la paradossale corruzione che ha coinvolto in lungo e largo tutte le strutture dello Stato e del partito – solo di recente contrastata con una certa risolutezza dalla direzione compattatasi attorno a Xi Jinping -, ma per la distruzione quasi sistematica di tutti i garantismi sociali che in epoca “maoista” erano stati in qualche maniera assicurati e soprattutto perché si sono prodotte sperequazioni sociali e differenziazioni di reddito incredibili. Valga per tutte la valutazione di alcuni studiosi occidentali che ritengono di poter sostenere come i 500 uomini più ricchi della Cina possano vantare un reddito pari a quello di 900 milioni di persone per due anni; o l’altra attribuita alla Banca mondiale che ha riferito come nel 2010 l’1% si è appropriato del 41% del reddito nazionale; e questo magari nel nome di un non meglio identificato “socialismo con le caratteristiche cinesi”, dove, come si commenta sotto voce a Pechino, le “caratteristiche cinesi” sono evidenti, mentre del “socialismo” non c’è più traccia di sorta.
Tuttavia, al di là di ovvie considerazioni su un modello di sviluppo che ha visto privilegiare la sorte di strati sociali ben precisi, è evidente come tutto ruotasse attorno ad un aggancio al mercato mondiale, vuoi per la penetrazione dei capitali che dovevano sostenere gli investimenti, vuoi per la destinazione delle merci prodotte grazie allo sfruttamento più bestiale di una forza-lavoro alla quale era sistematicamente negata ogni forma di difesa o di rappresentanza sindacale; bastava il verbo sufficiente propinato di volta in volta dalle eminenze grigie del regime o dalla fazione che prevaleva al termine di faide furibonde per garantirsi il controllo dei centri di potere che contano.
Questo quadro di riferimento che ha comunque garantito uno sviluppo complessivo delle forze produttive ha di fatto conosciuto una brusca contrazione con lo scoppio della crisi nel mondo occidentale nel 2008; in pratica i capitali hanno cominciato ad affluire in Cina in maniera meno copiosa, mentre le merci cinesi non trovavano adeguatamente acquirenti fuori dai confini nazionali. Come conseguenza si doveva registrare il fallimento di 67.000 aziende piccole e medie, con conseguente licenziamento di circa 20 milioni di lavoratori che dall’oggi al domani andavano ad ingrossare le file dei disoccupati. Il gruppo dirigente che nel momento dato si raggruppava attorno a Hu Jintao si vide costretto a reagire non fosse altro per evitare ricadute sul piano sociale dalle ripercussioni imprevedibili; venne così lanciato un piano di investimenti pubblici pari a 642 miliardi di dollari per rilanciare uno sviluppo che, rimesso a se stante, sembrava avviato verso un tendenziale declino.
Il risultato è stato comunque estremamente contraddittorio; da un lato infatti il declino economico è stato in qualche maniera arginato, ma al tempo stesso questa poderosa emissione di danaro da parte delle autorità centrali contribuiva ad alimentare il debito pubblico che, secondo le stesse stime ufficiali, raggiungeva l’astronomico ammontare complessivo di 3,4 trilioni di dollari, anche se su questo dato ha influito in maniera considerevole l’azione dissennata degli organismi periferici che, pur di far fronte alle esigenze più disparate, non hanno esitato a lasciare penetrare capitale speculativo (hot money) previa l’iniziativa non proprio ortodossa delle “banche ombra” (shadow banks), con il risultato non esattamente incoraggiante di contribuire a determinare una vera e propria crisi del debito (credit crunch), con il conseguente rischio di dare luogo ad una catastrofica crisi finanziaria generalizzata. A ciò si aggiungevano spinte che portavano alla sovrapproduzione (overcapacity) di alcuni settori primari e la tendenza a far convergere risorse cospicue verso una sorta di finanziarizzazione dell’economia, nel senso che troppe risorse finivano con l’essere dirottate verso il settore bancario piuttosto che verso l’economia reale e i settori produttivi.
In breve un contesto di fattori che ha indotto la nuova leadership che è emersa al XVIII Congresso del PCC a varare una sorta di svolta pur di rimettere in piedi l’andamento del processo produttivo che ormai presentava pericolosi sintomi di deterioramento. In pratica niente più stimoli statali per sostenere l’economia – come patrocinato sinora da Hu Jintao e i suoi – ma snellire le procedure e annullare i controlli preventivi degli organismi centrali, per poi rimettersi alle forze salvifiche e propulsive del mercato; di conseguenze oltre 300 provvedimenti che prima richiedevano la preventiva autorizzazione delle autorità governative ora possono essere liberamente messi in atto dalle imprese private; nel contempo molte funzioni venivano delegate a quelle autorità periferiche che poco prima erano state additate al pubblico ludibrio come le maggiori responsabili di quel debito pubblico che aveva raggiunto importi astronomici sin da mettere in dubbio la capacità dell’intero sistema di reggere nei tempi medi o lunghi.
Tuttavia il quadro complessivo che deriva dall’adozione non proprio organica di questi provvedimenti rimane caratterizzata da grande incertezza. Resta inteso che la Cina può ancora vantare un tasso di crescita abbastanza sostenuto, in virtù anche del rafforzamento dello yuan e del dinamismo sui mercati internazionali dove l’ampia riserva di valuta estera ammontante a circa 3.300 miliardi dollari consente alla Chinese Investment Coorporation di finanziare operazioni estremamente efficaci. Ma è chiaro che tra le mura domestiche si delineano tendenze che marcano un declino sostanziale e il venir meno delle spinte più dinamiche e propulsive di quella “riforma” avviata da Deng Xiaoping nel’78 che sinora aveva assicurato tassi di crescita estremamente sostenuti. I dati statistici al riguardo appaiono incontrovertibili; se infatti prima della crisi del 2008 la Cina poteva vantare un incremento del PIL che si aggirava attorno al 14,7% annuo, nel 2013 si è passati al 7,3%, mentre per il 2015 gli analisti pronosticano il 6,8% e per il quinquennio 2020-2025 si prevede un saggio di crescita che dovrebbe oscillare attorno al 3,9%.
Chiaramente questi dati previsionali impongono cautela e attendono la verifica empirica dallo sviluppo degli eventi; tuttavia è indubbio come già ora si delinei la precarietà del progetto di Xi Jinping, se è vero che in men che non si dica si è proceduto a prospettare significative correzioni, per cui di recente si è parlato di nuovi “stimoli” governativi – cioè si fa riferimento ancora una volta a quelle procedure che sembravano in auge quando a menare la danza era Hu Jintao e che erano state giubilate come inadeguate – che per 2015 dovrebbero raggiungere il valore di 115 miliardi di dollari. Con quali ripercussioni sulla dilatazione del debito pubblico non è dato di conoscere.
Difficile valutare in anticipo le ripercussioni sociali e politiche in relazione alle prospettive che sembrano delinearsi nella Cina postdenghista, anche se il regime, magari con disinvoltura degna di miglior causa, persiste nel presentare il tutto come perfettamente in linea con il proprio progetto che d’ora innanzi porrebbe l’accento in misura prioritaria sullo sviluppo “intensivo”, il rinnovo tecnologico autoctono – e non più mediato dalle importazioni dei manufatti stranieri – e l’aumento dei consumi interni in modo da puntare in maniera decrescente sulle esportazioni.
Tuttavia, al di là di queste valutazioni ispirate ad una logica più che altro autogiustificativa, è chiaro come la tendenziale riduzione del saggio di crescita ponga in prospettiva seri problemi ai vertici del regime, quell’apparato dominante che ha progressivamente annullato tutte le caratteristiche che la società cinese aveva assunto al termine dell’esperienza rivoluzionaria e che, a dispetto della più recente ricerca di un quadro di riferimento ispirato ad una maggiore ortodossia legalitaria, continua a gestire il potere in maniera quasi esoterica e comunque al riparo da qualsiasi coinvolgimento provenga dalla società civile.
In concreto un intersecarsi di fattori che potrebbe delineare il logoramento di quel “patto non scritto” – di cui ha parlato più di un osservatore occidentale – secondo il quale la società civile continuerebbe ad accettare di essere espropriata dell’esercizio dei propri diritti politici, in cambio di uno sviluppo che garantisca migliori condizioni di vita; il che, viste le tendenze che si delineano all’orizzonte, sembra che vacilli paurosamente, liberando forze centrifughe e spinte eterogenee rivolte a riconsiderare il contesto dei problemi all’ordine del giorno al di là dei canoni un po’ angusti proposti dai detentori intangibili del potere. Anzi, processi di questa natura già si delineano all’orizzonte e già operano sotto traccia se gli “incidenti sociali” nel 2011 hanno superato quota 200.000, mentre episodi del genere nel 2013 e nel 2014 si sono moltiplicati a tal punto da indurre le eminenze grigie del regime a disporre la sospensione della diffusione dei dati.
In breve un contesto di elementi di giudizio che ha indotto i vertici del regime ad assumere qualche iniziativa per ricompattare quel corpo sociale dove ormai pullulano le spinte più dissimili e le pulsioni più disparate. In primo luogo si è proceduto ad una paradossale quanto anacronistica rivalutazione della figura di Confucio e quindi delle sue elaborazioni attinenti “l’armonia sociale”dove, per uscire da ogni metafora puramente allusiva, tutto si riduce alla più passiva accettazione dei classi subalterne delle scelte e della opzioni messe a punto dal potere costituito. Poi si è passati ad una riesumazione della concezione “maoista” della “linea di massa” che, al di là delle successive interpretazioni apologetiche, si è sempre tradotta in un coinvolgimento dei settori popolari su progetti elaborati dal ristretto nucleo dirigente del partito, sul quale, manco a dirlo, le “masse” non sono mai state chiamate a dire la loro in fase di elaborazione, né a proporre modifiche al momento della loro esecuzione.
Infine la prospettiva di irregimentare in anticipo gli intellettuali – prospettando loro la possibilità di essere inviati nelle campagne a “imparare dai contadini”– perché con ogni probabilità si ha motivo di ritenere che proprio dagli uomini di cultura potrebbero venir fuori le riflessioni più significative sulle scelte di fondo messe a punto dal potere costituito, per poi dare luogo a progetti che delineino effettive soluzioni alternative; insomma chi di dovere intenda che non sarà dato spazio di sorta ad elaborazioni che sortissero autonomamente dal corpo sociale e che eventualmente trovassero proprio negli intellettuali il terreno fertile per messe a punto antitetiche a quelle propinate dall’apparato dominante.
In definitiva di fronte alle ipotetiche tensioni sociali che la Cina di qui a breve potrebbe conoscere l’alternativa è posta: o ci si adegua al ricompattamento sociale di orientamento paternalistico-correttivo prospettato dalla nuova dirigenza emersa al XVIII Congresso del PCC o si dovranno subire le mene repressive della burocrazia dominante, magari finendo in qualche anfratto remoto delle campagne cinesi.
Un progetto che, ad ogni buon conto, si dovrà commisurare con lo sviluppo effettivo degli eventi e con numerose variabili di natura economica, sociale e politica difficilmente valutabili al momento. E non è detto che nella Cina di Xi Jinping tutto fili liscio secondo le aspettative dei vertici del potere. Nella Cina postdenghista le incertezze e le previsioni dubitative prevalgono nettamente sulla consistenza dei dati certi».
* Fonte: Sinistra Anticapitalista


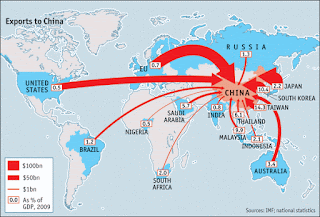


Nessun commento:
Posta un commento